
Ogni storia di anoressia è una storia a sé. Diversa da altre, forse simile, magari uguale. Un giorno mangi poco, quello successivo ancora meno, il terzo meno del primo e del secondo, il quarto ancora meno dei primi tre. Ci si distacca dal cibo in un’insensata guerra che coinvolge se stessi e chi si ama. Già, chi si ama: nel mio caso – avevo quindici anni –, i miei genitori. Mia madre non si dava pace e non mi dava tregua, mi controllava a vista e si disperava. Mio padre non si dava pace, mi stava meno addosso, e si disperava. Ma la loro disperazione rafforzava – e consolidava – il mio proposito di continuare: mangiavo sempre meno e deperivo sempre di più.
Ero sempre stanca, molto stanca. Ma non lo ammettevo. Non potevo, né dovevo. La mattina quando mi alzavo per andare a scuola spesso mi girava la testa, ma dovevo alzarmi e mi alzavo, mi infilavo i vestiti larghi e uscivo.
C’era lo studio e c’erano gli studi medici. Lo psicologo, il ginecologo, il medico amico di famiglia, l’endocrinologo: mi portarono da tutti. Li lasciavo parlare, loro scrivevano e prescrivevano analisi, terapie e medicine. Ma io andavo avanti, ostinata e imperturbabile. I mesi scorrevano – ne erano passati più o meno sette da quel primo giorno -, e i chili scendevano. Arrivai a pesarne 29: un peso miserabile che si rivelò la mia salvezza.
“Se continui così te ne vai all’altro mondo.” Quelle parole – pronunciate da un medico dell’ospedale dove fui ricoverata – finalmente mi spaventarono. Stavo sfiorando la morte, ma non volevo morire.
Riprendere a nutrirsi è stato più complicato che smettere. Difficile e lungo ma possibile. E soprattutto volevo farcela, lo dovevo a me stessa, ma non solo.
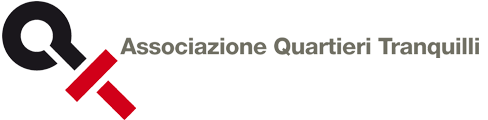
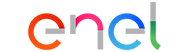

 QUARTIERI TRANQUILLI
QUARTIERI TRANQUILLI










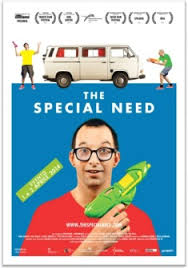

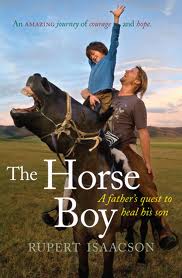












 QUI LINA
QUI LINA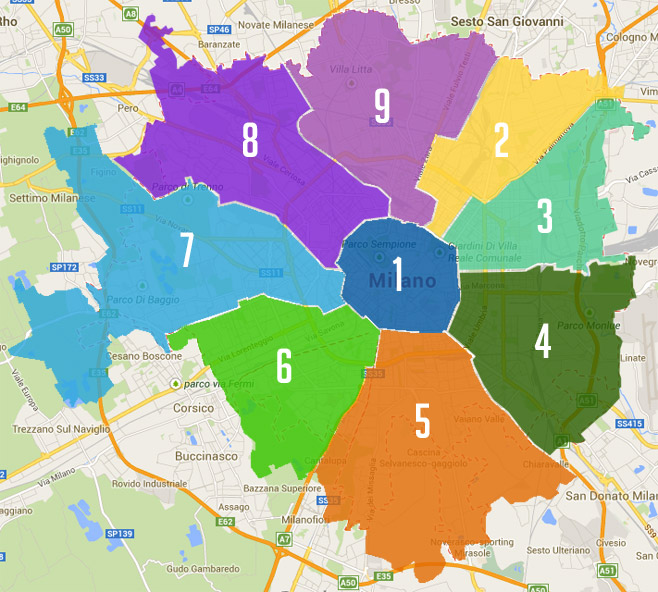


 @LINASOTIS
@LINASOTIS I TWEET di QT
I TWEET di QT



