In cold blood non e` un titolo per ragazzine.
Quando mi e` capitato tra le mani per puro caso la prima volta, avevo su per giu` quattordici anni e stavo curiosando tra gli scaffali della biblioteca comunale. L’ho rigirato senza aprirlo per un lungo istante, dubbiosa; poi, come se di colpo mi avesse graffiata, l’ho rimesso al suo posto. Non era il mio genere, non mi piaceva la copertina, e il titolo mi metteva paura. Provai una sorta di avversione a pelle, un’antipatia improvvisa per il nome e cognome dell’autore che mi suonava strano, minaccioso.
Ero troppo sprovveduta all’epoca, e troppo conformista per lasciarmi sedurre da uno scrittore cosi` ambiguo, e brutto. Ma fu proprio la bruttezza del suo volto a rimanermi impressa per anni. Nessuno mi aveva mai parlato di lui, ne´ gli amici ne´ i professori. Nessuno, nella cerchia dei miei compagni di classe, lo aveva letto. A sangue freddo non era – a differenza, per esempio, di On the road di Kerouac – un libro di moda, di cui potersi vantare nei corridoi del liceo durante la ricreazione. Era un titolo inquietante, punto.
Era una brutta faccia inquietante.
Ho continuato a schivarlo per tutta la durata delle superiori, come se fosse un libro appestato; e Capote, puntualmente, ha continuato a finirmi tra le mani in tutte le librerie e le biblioteche. Come accade per i grandi amori dei feuilleton ottocenteschi, la casualita` e il fato tramavano per farci incontrare. Era una questione tra me e lui, tra il suo enorme coraggio e il coraggio che io stavo provando a tirare fuori.
All’universita` cominciai a cercare sue foto su internet, e le trovavo una piu` rivoltante dell’altra. La sua bruttezza continuava a tenermi sulle spine. Perche´ non era una bruttezza qualunque; il suo era un volto abissale. Digitavo « Truman Capote » su Google con la stessa apprensione morbosa che ti prende la pancia quando cerchi informazioni su un assassino; mi appropriavo di soppiatto di
brani della sua vita balzando da una biografia all’altra. Ficcanasavo e rimestavo, ma mi tenevo ancora alla larga dai suoi romanzi. Mi guardavo bene anche dal leggerne una sola riga. Un’infanzia difficile, un padre assente, una madre diciottenne che avrebbe preferito abortire. Un secondo padre, adottivo e cubano. Una seconda identita`, omosessuale ai tempi in cui l’omosessualita` era un tabu` inconfessabile. E poi, quell’illuminazione folgorante avvenuta su un marciapiede all’eta` di dieci anni, prendendo a calci un sasso un pomeriggio: « Devo fare lo scrittore ». Per prima cosa, mi sono innamorata della sua vita.
« Sono un alcolizzato. Sono un tossicomane. Sono un omosessuale. Sono un genio. » Quando ho deciso di ribellarmi definitivamente al conformismo, questa dichiarazione di Capote mi ha fatto
l’effetto di un colpo di fulmine. A sangue freddo, c’era il sangue dentro quel titolo. E lui era ancora li`, mi aspettava al varco. Ho dovuto perdere la migliore amica, il posto alloggio nello studentato e la borsa di studio prima di decidermi a comprare quel dannato libro. Era il 2009, ero a un passo da una laurea in Lettere che mi avrebbe offerto, forse, ben che mi andasse, qualche settimana di supplenza l’anno. Non sapevo dove sbattere la testa, e avevo bisogno di qualcosa di forte. In cold blood suonava promettente come un whiskey o una droga pesante.
Adesso ero pronta. In uno squallido bilocale per studenti, nel quartiere forse piu` brutto di Bologna e in uno dei peggiori inverni della mia vita, una sera di gennaio ho aperto il romanzo che mi tormentava da
anni, ho sfidato l’autore che tra tutti mi era piu` antipatico, e l’ho fatto con astio, piena di pregiudizi, aspettandomi solo di litigarci come in quel periodo litigavo con tutti.
La prima pagina fu un pugno allo stomaco. Come la prima sigaretta fumata di nascosto alle scuole medie, che ti fa piegare in due per la tosse e allo stesso tempo ti fa sentire potente. Per settantadue ore ho dormito poco, mangiato male e non ho messo piede fuori dalla tana in cui mi ero cacciata. Ho amato Capote come si ama solo un uomo destinato a rimanere per sempre al proprio fianco. Settantadue ore filate di splendido inferno.
« Gli ultimi a vederli vivi »… e` il titolo della prima parte e dice gia` tutto. Non e` essenziale, o forse lo e`, ma sta di fatto che tutti i nomi e cognomi di questa storia sono stati registrati all’anagrafe della realta`, e piu` precisamente in quella di Holcomb, « un confuso agglomerato di edifici diviso al centro dai binari della Ferrovia
per Santa Fe ». Qui, la notte tra il 14 e il 15 novembre del 1959, un’intera famiglia e` stata trucidata.
E ` stata trucidata davvero.
Questo fatto di sangue ha riempito le sezioni di cronaca nera dei quotidiani dell’epoca, in tutti gli Stati Uniti. Padre ricco e self-made-man, madre fragile ma premurosa, figlio forte e adolescente, figlia sedicenne ottima cuoca e fidanzatina perfetta. I campioni del sogno americano, tutti e quattro freddati come bestie. Le cronache si sbizzarriscono, arrivano giornalisti e ficcanaso da ogni Stato. E arriva anche lui, Truman Capote, che dopo Colazione da Tiffany e` diventato famoso, ha fatto un mucchio di soldi e si e` ritrovato senza piu` un briciolo d’ispirazione.
L’articolo di giornale sui Clutter barbaramente assassinati in Kansas era il pretesto che stava cercando per rimettersi in moto, la molla feroce della creativita`. Capote sale su un treno e va dritto a Holcomb. Si stabilisce li` per tre mesi. La gente del posto gli gira alla larga: e` ancora sconvolta dall’accaduto, ha gli occhi gonfi per l’insonnia. Nessuno si sogna lontanamente di parlare con quello scrittore, che chissa` cosa diavolo vuole, ed e` venuto fin qui da New York.
Ma Capote non si arrende, si arma di santa pazienza, e stana uno ad uno la barista, il custode del ranch dove e` avvenuto il massacro, la capostazione, gli agenti della Contea. Li costringe a parlare, con le buone, conquistando la loro fiducia. Conduce la sua personalissima inchiesta, ma non lo fa per un giornale, non lo fa per ingolfare ulteriormente la cronaca nera di dettagli macabri e morbosi. Lui ha altre ambizioni, e vola decisamente alto.
Herbert, Bonnie, Kenyon, Nancy Clutter. Non hanno nemici.
Tutti li conoscono a Holcomb, tutti li stimano e li ammirano, per giunta senza invidia. Per quale motivo qualcuno avrebbe dovuto odiarli? Sono sempre stati lavoratori indefessi, timorati di Dio e praticanti ogni domenica; sono la famiglia – diremmo noi – del Mulino Bianco, senza macchia, senza paura e con tanti soldi. Nei loro armadi non si nasconde neppure l’ombra di uno scheletro. Tutto quello che hanno se lo sono guadagnato con il sudore e la fatica. Eppure, questo non e` bastato a metterli in salvo. Capote scava nelle loro vite con l’acribia del filologo, con la meticolosita` del medico legale. Va giu` fino al dettaglio, viviseziona i diari immacolati di Nancy, le abitudini tranquille e monotone di Herbert che si alza tutte le mattine alle sei e fa colazione con una mela…
Dentro la perfezione realizzata del sogno americano non si agita nessuno spettro. Tutto procede tranquillo nella routine della vita di provincia. Gli spettri non sono dietro o dentro i Clutter. Gli spettri sono fuori. Sono i tagliati fuori, gli esclusi, i nessuno, gli emarginati, gli invisibili che si agitano anche nelle banlieues francesi e nelle periferie italiane, nel 1959 come nel 2009.
Capote ce li presenta subito dopo averci presentato i Clutter nel loro ultimo giorno di vita. Uno stacco di riga bianca, un balzo di un centimetro, ed eccoci dall’altra parte della barricata, nella meta` oscura del sogno americano. Si chiamano Perry E. Smith e Dick E. Hickock. Dalla nascita non hanno ricevuto altro che pedate nel sedere, sono finiti in prigione, ne sono usciti con la liberta` vigilata, e adesso si trovano in
un bar per mettere a punto un piano cullato da tanto tempo. Quella che stanno architettando e` la svolta della loro vita, una rapina che possa sistemarli una volta per tutte, in Messico, come due nababbi. Perry, figlio di alcolizzati, e` mezzo indiano, ha le gambe corte e rovinate da un incidente d’auto, e va avanti ad aspirine e gazzosa per tenere a bada il dolore. Dick ha avuto due mogli e le ha deluse entrambe, ha dei figli a cui non puo` dare un futuro, come del resto suo padre non l’ha dato a lui. Emette assegni a vuoto, e` abbagliato da una ricchezza al di fuori della sua portata, e sfoga la sua frustrazione investendo i cani che gli attraversano la strada.
Sono due ragazzi della mia eta`, due disgraziati come tanti. Sono due mostri.
Solo che Capote, a differenza di qualsiasi telegiornale o pagina di cronaca nera, ce li fara` conoscere a fondo, ci raccontera` tutta la loro storia dall’infanzia all’adolescenza fino al delitto. Ce li fara` vedere agonizzanti sulla forca, ci fara` sentire la loro ultima parola prima che il cappio stringa intorno al collo, e con questo ci mettera` in una posizione parecchio scomoda, anzi: la piu` scomoda di tutte.
Qualcuno dice che Capote, dopo che furono arrestati e chiusi nel braccio della morte, a forza di scriversi con Perry e Dick abbia addirittura rischiato d’innamorarsi di loro. Quello che e` certo, e` che questo scrittore « alcolizzato, tossicomane, omosessuale e geniale » e` vissuto a stretto contatto con i due assassini per piu` di sei anni, li ha seguiti durante le indagini, la cattura, la detenzione e l’esecuzione.
Perry e Dick lo hanno scongiurato di essere presente alla loro impiccagione, e di scrivere tutto, di non tralasciare niente. Visto che la legge non li avrebbe salvati, volevano essere salvati almeno da lui, da Capote. Questi due feroci nessuno hanno avuto il coraggio di credere davvero al potere della letteratura.
Capote ha esaudito i loro desideri; li ha tenuti in vita nel suo romanzo, nella nostra lettura. Una lettura che azzera di colpo tutte le volgarita` della cronaca nera a cui siamo abituati, che la pulisce da tutte le scorie morbose e dalle semplificazioni degli opinionisti, e ci restituisce il volto terribilmente umano che ogni assassino ha, anche il peggiore. Ci costringe a venire a patti con i mostri, come se fossero i nostri figli o i nostri genitori. Ci costringe a venire a patti con noi stessi.
In cold blood esce negli Stati Uniti nel 1966, in quattro puntate sul New Yorker. Il delitto dei Clutter era gia` stato dimenticato da un pezzo, come sempre accade nell’abbagliante regno dei media. Capote stravolge le regole del tempo, e con il suo romanzo riaccende l’attenzione a livelli sensazionali. Il pubblico americano legge avidamente, freme in attesa della puntata successiva. Succede di tutto: si alzano voci scandalizzate, voci indignate, impazzano le polemiche. A sangue freddo diventa un best seller, viene recensito favorevolmente sia in America sia all’estero, ma non riceve il premio Pulitzer.
Dopo, Capote continua a lavorare moltissimo. Ma il capolavoro e` gia` stato scritto e adesso, inevitabilmente, comincia la china. Aumentano le droghe e le bottiglie di vodka. Morira` di cirrosi epatica nel 1984, proprio nell’anno in cui sono nata. Quando ho chiuso il libro, mi tremavano le mani. Ho fatto un paio di giri a vuoto per la stanza, senza sapere che fare e come smaltire la dose folle di adrenalina che mi sentivo in corpo. Avevo appena letto il libro piu` crudele e anche, forse, il piu` generoso.
Avevo appena assistito all’impiccagione di Perry e Dick, e non potevo accettarla. Mi sentivo frastornata come una cittadina di Holcomb, come doveva essersi sentito Truman Capote nella camera delle esecuzioni.
Ero rimasta con un mistero tra le mani, piu` grande di me, intatto e chiuso come un uovo. Ero ancora, e piu` di prima, senza vie d’uscita nel mio bilocale e con una laurea al momento inutilizzabile, in una societa` che mi riproponeva tutti i problemi che aveva posto all’America degli anni Sessanta. Ma fremevo di entusiasmo, fremevo dal desiderio di cambiare le cose, in qualche modo, se non altro con le parole che servono, con le parole necessarie a scavare e a guardare in faccia la realta`. Quella stessa realta` che Capote aveva descritto e che pulsava la` fuori, attraverso i vetri della mia finestra.
Ho sempre amato i libri capaci di uscire dalla carta e di creare scompiglio, movimento, rivoluzioni nella vita reale, nelle epoche, in intere generazioni. Ogni libro bello che ho letto mi ha sempre messa in agitazione, mi ha insegnato che la vita degli altri mi riguarda. Ma nessuno me lo ha marchiato a fuoco nella memoria come In cold blood.
pubblicato per gentile concessione di Longanesi, tratto da I libri ti cambiano la vita. Cento scrittori raccontano cento capolavori, a cura di Romano Montroni.
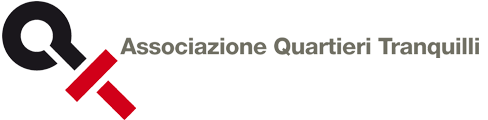
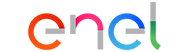

 QUARTIERI TRANQUILLI
QUARTIERI TRANQUILLI






E’ un ottimo romanzo, ho trovato però poco elegante la festa finale a chiusura del libro. Sul “sangue” di due impiccati e. prima di loro, di una famiglia sterminata. Alla festa c’erano anche Marella e Gianni Agnelli vestiti in bianco e nero. Forse anche questo è New York.