Prima di entrare nel recinto dell’attesa, ero Cinzia: Avevo un’identità definita; esistevo per realizzare il mio progetto di essere per comprendere le intenzioni e le emozioni degli altri, altri che per empatia o casuale incontro, avrebbero edificato insieme con me un comune progetto di vita. Esistevo e per coscienza del sé, ero capace di occupare lo spazio con la mia voce, con il mio corpo, con la consapevolezza d’essere materia vibrante, strumento capace di trasformarsi, incontrarsi, adattarsi, mescolarsi, essere nello spazio lo spazio intero, essere a tempo per esserne il tempo.
Avevo dei motivi validi per cui soffrire e dei rimedi semplici per curarmi. Avevo un dolore orgoglioso da esibire che mi aiutava a comprendere quello degli altri; gioia da accoppiare con chiunque incontrasse il mio sorriso. Il mio linguaggio serviva a riconoscermi per prepararmi all’ascolto; il mio linguaggio serviva alla comunità come il loro a liberare le energie e la storia culturale della parola compresa al di là delle differenze sociali, culturali, ambientali, religiose….Parola seguita per primordiale appartenenza dal mio corpo. Danza di gesti e di umori sulle espressioni del viso, danza tribale di conversazioni mute. Diaframma aperto per liberare un urlo, un dolore, una gioia, una canzone toccando l’ottava. Diaframma chiuso per quietare una nostalgia, sussurrare un segreto, tacere ad una provocazione.
Oggi nel recinto dell’attesa mi chiamo per cognome e sono al centro di un orologio biologico caotico. Le mie braccia la misura dello spazio consentito, lancette di un tempo impersonale, dove tutto inizia senza mai iniziare realmente, dove il niente non termina mai, tempo di un luogo al confine ultimo dell’umanità: Il mio linguaggio è quello dei bambini, consapevole appena di due tre frasi che servono, bastano a chiedere cose già pre-autorizzate, a rispondere a domande rumorose, telegrafiche: Uno stadio non evoluto dell’umano sentire , primitivo comunicare quanto basta a non chiedere. Così è se vi pare
Il carcere, enorme ventre di matrigna perennemente gravida, ingorda di figli mai pronta a partorirli perché anziché nutrirli, di loro si nutre.
Il carcere, contenitore e inibitore di tutti i colori e le melodie del mondo. Tamburo dallo scheletro di ferro e dalla pelle tirata a sangue che batte il tempo, controtempo, di ogni sentire.
Il carcere, padrone assoluto della nostra libertà, contagocce dei bisogni minimi, fondamentali; esserne privati significa essere attaccati profondamente nella dignità.
Il carcere, profanatore del nostro io, con l’obiettivo di portarci allo stato embrionale, strappandoci qualsiasi identificazione con il mondo esterno e con la storia di ognuno di noi.
Il carcere, unico luogo al mondo, copia esatta del nostro incoscio, maestro elementare che ha l’obbligo di renderci “nuovamente abili” attraverso l’osservazione scientifica della personalità.
Venute al mondo, nate qui, ridotte ad una condizione di debolezza, sottomissione, dipendenza. Nate qui, private di ogni privato; sventrate le nostre culle, distrutte le costruzioni, profanate le bambole e i peluche. Corti abbracci di madri e di figli che non arrivano a stringersi. Nate qui, ci riconosciamo per paura di essere rimaste uniche al mondo, che fuori è guerra e sangue e questo bunker ci salva ogni giorno. Nate qui, aggrappate l’una all’altra ci raccontiamo una realtà distorta, enfatizzata, studiata per sopravvivere a noi stesse. Vive per morire di mille morti quotidiane, vive per inerzia, vive per slogan. Nate qui, mischiate l’una sull’altra, l’una per l’altra senza differenza, come fossimo un pezzo di carne, una sola identità. Caos, questo regna sovrano.
Subisco la metamorfosi Kafkiana. Il mio corpo muta, i muscoli si prolassano sulla pelle, il mio sguardo non è mai fisso, gli occhi si muovono nervosamente seguendo frammenti di immagini e pensieri fulminei. Istantanee di vita trascorsa: Ciechi al presente, offuscati al futuro. Sono una donna disturbata dagli eccessi di rumori uguali, di gesti ripetitivi, contaminata dall’immobilismo fisico e intellettivo. Ho perso il centro di me stessa, il mio baricentro si è spostato, le mie spalle tendono a chiudersi verso lo sterno, il collo piegarsi in avanti. Il mio passo è breve, il pensiero affollato, veloce. Il dialogo incespica tra un turbinio di parole perse nella memoria. Balbetto, perdo il filo del discorso, perdo il tempo. Non dialogo ma invoco ascolto, comprensione e il mio corpo s’inginocchia a questa supplica. La metamorfosi arriva all’apice quando nessuno circola attorno a me. Quando tutto è muto e sordo, nessuno mi vede e io non ci sono.
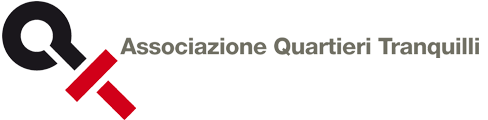
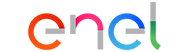


 QUARTIERI TRANQUILLI
QUARTIERI TRANQUILLI





